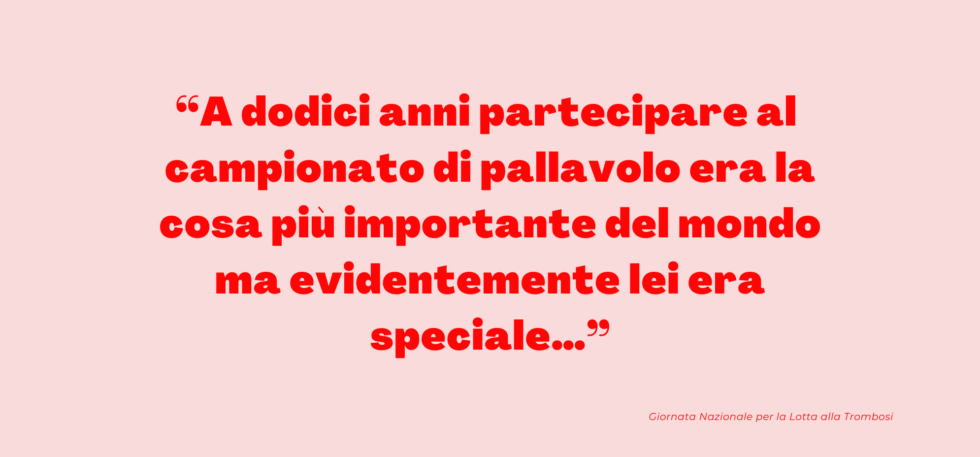L’allenatore l’aveva messa in squadra, finalmente, e lei sentiva di meritarlo: non era proprio una spilungona, però aveva una buona battuta, e una immensa passione per la pallavolo che faceva dimenticare quello che le mancava in altezza.
Per due o tre giorni aveva tenuto nascosto un segreto: non riusciva a stare bene in piedi, ogni tanto all’improvviso il mondo intorno cominciava a girare come se fosse appena scesa dalle giostre. E si sentiva la febbre, le ossa rotte e la gola bruciava quando deglutiva la saliva.
Le faceva male soprattutto sotto l’orecchio, a guardar bene era anche un po’ gonfia.
Ma non era una lamentosa e a dodici anni partecipare al campionato era la cosa più importante del mondo…
Adesso si sentiva disperatamente in colpa: forse aveva fatto male, a non parlare con sua madre subito, e aveva provocato un sacco di guai a tutti. La squadra aveva giocato senza di lei, perché lei era in ospedale.
Ictus che colpisce il cervelletto aveva detto il medico: mai sentito nominare. Nemmeno in scienze.
Invece lì in ospedale tutti sembravano conoscerlo molto bene.
Tutti i medici che passano a vederla, a dire il vero avevano anche la faccia preoccupata, tutti, tranne una; quando era entrata in camera la prima volta le aveva messo un po’ di soggezione: forse erano i capelli raccolti in una coda severa, forse gli occhi attenti, azzurri, un po’ distanti. Era una donna grande, con grandi mani, e si muoveva sicura; le aveva ascoltato il cuore, chiudendo gli occhi per concentrarsi, le aveva toccato la pancia, il collo, le gambe, guardato in gola, sentito il respiro, piega le ginocchia, apri la bocca… Ma le era piaciuta quando aveva cominciato a parlare: parole semplici, parlava di tubi, di un sistema idraulico tipo quello di casa, in cui il calcare provoca incrostazioni che a volte si staccano, e tappano il rubinetto facendo scendere meno acqua…
Un frammento di qualcosa si era staccato dal suo cuore, e viaggiando era andato a tappare un’arteria addetta a portare il sangue al cervelletto (non aveva detto cervellone, aveva detto cervelletto: tanto «etto» non doveva essere, evidentemente aveva la sua importanza, visto che lei non stava in piedi…).
L’imbroglio era partito dal mal di gola: nessuno aveva pensato ad altro che a quello, le avevano dato gli antibiotici e le avevano spiegato che l’infezione aveva prodotto del catarro dentro l’orecchio, nella parte che non si vede, e siccome lì sta l’organo dell’equilibrio, per questo lei non stava in piedi.
Sarebbe andata meglio in pochi giorni, appena l’antibiotico avesse fatto effetto. Invece non era andata meglio per niente: la febbre se ne era andata e anche il gonfiore, ma lei non camminava meglio, anzi, si sentiva come una bambola di pezza, quando la mettevano in piedi si afflosciava da una parte, e non riusciva più a parlare, biascicava come un vecchietto, e metà della stanza era come se fosse stata sbiancata da un pittore pazzo ed era sparita.
Adesso sì, le cose andavano meglio. Da quando era arrivata in quell’ospedale un po’ celeste e un po’ arancio, tutto pulito, dopo che era entrata e uscita da una macchina che sembrava un sommergibile, adesso si sentiva meglio.
Non era tanto contenta che le dovessero bucare la pancia due volte al giorno con le iniezioni, anche se onestamente non le facevano poi tanto male, ma si era accorta che le cose andavano meglio: il pittore pazzo aveva smesso di imbiancare metà della stanza, mancava solo un angolino ancora in alto, presto avrebbe smesso di toccare anche quello, ne era sicura, lei era riuscita a rimettersi in piedi. Faceva finta di essere una marionetta, e si concentrava sui fili immaginari che dovevano sostenere il suo corpo, mandando con il pensiero ordini perentori affinché la sollevassero e la facessero muovere come si deve, e tutto andava meglio.
Il medico che le stava facendo l’ecografia voleva a tutti i costi che lei guardasse nello schermo: ma lei aveva paura di fare la figura di quella che non capisce o non sa, non sapeva nemmeno che cosa fosse quell’esame.
Alla fine, si era convinta, e aveva fatto bene: l’immagine del suo cuore che si muoveva come in un cartone animato era carina, in bianco e nero, con le valvole che si aprivano e si chiudevano, il medico le stava spiegando per bene che cosa vedeva, e le indicava un piccolo buco che permetteva il passaggio del sangue da una parte all’altra del cuore, dicendo che quello non avrebbe dovuto essere lì, o meglio non avrebbe dovuto essere aperto.
Si chiamava forame ovale, formale perché era come un foro, una finestra, ovale perché non era rotondo. Veramente avrebbe dovuto chiudersi al momento della nascita; invece pare che la tendina che avrebbe dovuto chiuderlo fosse scesa solo in parte, permettendo che il sangue del cuore a destra si mescolasse con quello di sinistra.
Il sangue del cuore destro è sporco, destinato ad andare a ripulirsi nei polmoni, quello di sinistra è pulito, pronto per essere mandato agli organi. Se questi due tipi di sangue si mescolano si formano dei coaguli di sangue, che possono partire e andare a finire dove vogliono.
Ecco, le cose erano andate esattamente così: non era stata fortunata perché il coagulo era andato a finire proprio in un punto delicato; ma era stata fortunata perché qualcuno se ne era accorto, e le stavano dando medicine adatte a scioglierlo.
E poi aveva materiale sufficiente per la prossima ricerca di scienze senza praticamente studiare niente!
Rimaneva una decisione importante da prendere: il forame andava chiuso, non si poteva lasciare così: avrebbe potuto in futuro rifarle lo stesso scherzo. Il dottore aveva detto che non sono poche le persone che hanno il forame che non si è chiuso bene, come il suo, anzi sono tantissime: una su tre, quindi nella sua classe almeno otto! Ma solo lei aveva avuto quel problema: mancava un pezzo? Evidentemente lei era speciale.
In effetti la conferma arrivò dopo qualche giorno: nel sangue di Elena era presente una proteina mutata, il suo fattore numero cinque si chiamava Leiden, ed era un po’ zoppo: non era capace di regolare bene la coagulazione del sangue, l’aveva ereditato dalla mamma.
La mamma non aveva mai avuto un problema nella sua vita, eppure era proprio da lei che Elena aveva ereditato il fattore taroccato.
Per la verità non era nemmeno colpa della mamma, perché anche lei se l’era beccato da uno dei nonni, anche se ormai non si poteva più capire da quale. Forse dalla nonna che aveva sempre le gambe un po’ blu, gonfie, ogni tanto con delle brutte ferite che chiamavano ulcere.
E poi questo fattore V mutato, lei lo aveva da quando era nata: perché si era deciso solo a dodici anni di farsi vivo?
La dottoressa, quella un po’ severa, le aveva spiegato che quando nel corpo c’è una parte malata, o infiammata, il sistema della coagulazione del sangue si prepara a guarirla, aumentando i fattori che fanno coagulare il sangue. Questo poco è bastato perché nel suo sangue, già un po’ denso e in più gassato per colpa del forame ovale, si formasse qualche grumo (adesso Elena sa che si chiamano trombi e che quando viaggiano prendono il nome di emboli) che poi ha combinato il guaio.
Altra dottoressa, altro giro: sala operatoria, luci azzurrine, tutti mascherati, un po’ spaziali, e altro televisore nel quale vedere un nuovo cartone animato, con il suo protagonista.
Questa volta Elena non aveva voglia di guardare, le avevano iniettato in una vena nel braccio qualcosa che le faceva venire sonno, e aveva deciso di fidarsi.
Un ombrellino aveva risolto il problema: risalendo lungo una vena la dottoressa aveva spinto l’ombrellino chiuso fino all’interno del cuore, con un gesto rapido aveva pigiato un bottoncino che lo aveva aperto e stop, fine del problema, forame chiuso, e si ritorna in camera.
Per sei mesi Elena ha preso farmaci anticoagulanti: nel frattempo, un po’ perché lei è testarda, un po’ perché ha due genitori fantastici, un po’ perché la fortuna assiste gli audaci, ha ripreso a camminare perfettamente, a parlare come un essere umano e non come un alieno. Tutte le sere la sua pillolina, a volte mezza, a volte un quarto, una volta al mese un prelievo di sangue e un nuovo diario con le dosi del mese successivo: finito, tutto finito.
Sollevando la coppa del campionato della scuola, negli occhi della mamma Elena vedeva riflessa la coppa piena della sua gioia di vivere.